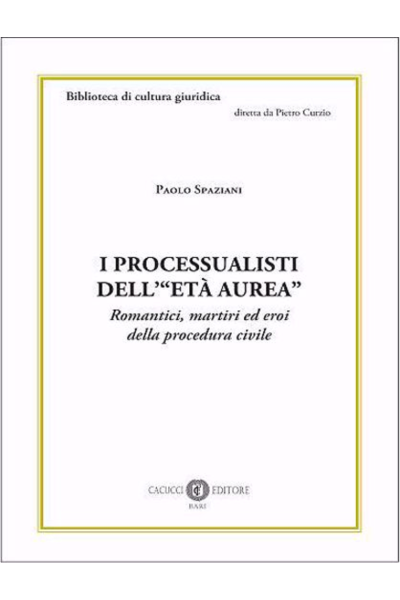I PROCESSUALISTI DELL'"ETÀ AUREA"
Romantici, martiri ed eroi della procedura civile
Regular Price
25,00 €
Special Price
23,75 €

Spesa minima per la spedizione gratuita: 60,00 €
NOTA: Valido solo per spedizioni in Italia
Tipologia Libri
Autore: Spaziani Paolo
Editore CACUCCI
Collana BIBLIOTECA DI CULTURA GIURIDICA
Pagine 292
Data pubblicazione 31 mag 2022
Argomento: Procedura civile
SKU/ISBN: 9791259651075
La storia dei grandi processualcivilisti dei primi decenni dello scorso secolo – scrisse Franco Cipriani – è una storia di «oligarchi», «nobile, rara e inestinguibile stirpe», i cui membri amano questionare, talora con la parola, più spesso con gli scritti. Le polemiche dottrinali, quasi sempre «fiere», come lo furono – secondo Bruno Cavallone – quelle tra Mortara e Chiovenda, riflettono non solo (e non tanto) la presunzione di ognuno di essere il detentore del primato, ma anche (e principalmente) l’inconsapevole coscienza di essere parti di una convivenza tanto più sofferta e contrastata quanto più coinvolgente e irrinunciabile; come l’«amicizia faticata» che avvinse per quasi un cinquantennio Carnelutti e Calamandrei.
Se le categorie metastoriche dell’arte potessero applicarsi ai membri di questa stirpe, qualcuno, forse, li potrebbe dividere tra apollinei e dionisiaci ripetendo, con Carnelutti, quella contrapposizione tra romantico e classico che lo studioso friulano, dinanzi alla salma di Calamandrei, riservò a se stesso e all’amico scomparso.
Altri, invece, estendendo a tutti i grandi processualcivilisti ciò che Calamandrei diceva di Carnelutti, potrebbero pensare che di queste categorie solo il dionisiaco si attagli alle «architetture grandiose … tra il michelangiolesco e il berniniano» della procedura, e si accingerebbero ad individuarne le tinte e il maggiore o minore solco delle diverse sfumature. Si materializzerebbe così, tra gli oligarchi della storia del processo civile (i processualisti dell’ “età aurea”), l’immagine sattiana della giustapposizione tra il giurista eroe e il giurista martire, entrambi immersi nella coltre romantica del dionisiaco, ma l’uno ripagato dalla certezza delle garanzie, l’altro tormentato dall’irraggiungibilità del vero.
Se le categorie metastoriche dell’arte potessero applicarsi ai membri di questa stirpe, qualcuno, forse, li potrebbe dividere tra apollinei e dionisiaci ripetendo, con Carnelutti, quella contrapposizione tra romantico e classico che lo studioso friulano, dinanzi alla salma di Calamandrei, riservò a se stesso e all’amico scomparso.
Altri, invece, estendendo a tutti i grandi processualcivilisti ciò che Calamandrei diceva di Carnelutti, potrebbero pensare che di queste categorie solo il dionisiaco si attagli alle «architetture grandiose … tra il michelangiolesco e il berniniano» della procedura, e si accingerebbero ad individuarne le tinte e il maggiore o minore solco delle diverse sfumature. Si materializzerebbe così, tra gli oligarchi della storia del processo civile (i processualisti dell’ “età aurea”), l’immagine sattiana della giustapposizione tra il giurista eroe e il giurista martire, entrambi immersi nella coltre romantica del dionisiaco, ma l’uno ripagato dalla certezza delle garanzie, l’altro tormentato dall’irraggiungibilità del vero.
Scrivi la tua recensione